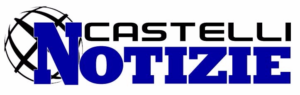In occasione della recente scomparsa di Domenico Buffarini, nato e cresciuto ad Albano, e frequentante del “Mancinelli” di Velletri, venuto a mancare all’età di 79 anni a Vicenza, dove da decenni risedeva, ospitiamo uno scritto in sua memoria del professor Pier Luigi Starace, che ne tratteggia un ricordo legato alle frequentazioni di gioventù.
RECONDITA ARMONIA
di Pier Luigi Starace
“Canterò “Recondita armonia”. L’aveva annunciato a voce bassa e leggera, in quella stanzetta d’un circolo universitario di Velletri, in quella fine autunno ’56, a noi matricole della “Sapienza” riunite per una festicciola. Aveva già appoggiato un piede su una sedia, come Cavaradossi, il busto appena chino in avanti, stringendo con la destra un bicchiere di vino bianco che gli avevo versato io stesso. L’alto attacco della romanza fece convibrare l’aria distratta del locale, la virgola del capriccioso ricciolo castano sulla vena turgida della sua fronte pallida, e la mia anima. Che percepiva in quella voce, ascendente d’impeto oltre ogni passaggio di quell’ardua vocalità, la tensione assoluta d’una “wille” fichtiana, lo scintillio d’un acciaio appena colato, l’ardore d’un torrente di magma. Credo d’aver sospeso la mia respirazione fino al suo acuto finale.
Lungo il resto della mia vita ho riascoltato innumerevoli volte quel pezzo da tutti i sommi, da Caruso a Bocelli, ma mai ho riprovato quell’emozione totale per un’espressione totale. In quella voce sentivo venire alla luce le mie sofferenze ascose, splendere l’altezza delle mie esigenze spirituali, vibrare quell’energia agonistica che i nostri compagni Augusto Venanzi, Luigi Arcarese e Tonino Pasquali Coluzzi effondevano nell’athlon, sugli stessi sentieri delle selve latine sfiorati un giorno da Turno, Niso ed Eurialo. La “wille”, dicevo. L’ideale dell’impegno nello studio, pur da entrambi noi onorato, non bastava più alla imperiosa febbre d’azione che ci cresceva dentro. E che fu fatta deflagrare dall’insurrezione ungherese.
In una scialba fine mattinata novembrina, nel distratto o rassegnato andirivieni della veliterna Piazza Garibaldi, Domenico mi si affiancò fremente:” Noi dovremmo partire per l’ Ungheria, andare a combattere a fianco degli insorti, come facevano i nostri patrioti!”. Non partimmo, ma Domenico, più di me, s’impegnò in un comitato per l’accoglienza di profughi ungheresi, del quale mio padre era parte trainante, anche per la sua conoscenza del tedesco. Domenico entrò allora più volte in casa nostra, ed io vidi nascere un’inaspettata simpatia, fondata sull’ammirazione per Beethoven, tra loro due. Me ne sentivo doppiamente orgoglioso: davanti a mio padre, per aver un simile amico, davanti a Domenico, per aver un tale padre. Una specie di ricevimento ufficiale degli esuli magiari al teatro Artemisio ebbe come pezzo forte la declamazione da parte di Domenico d’una poesia nata nelle carceri di Budapest in quei giorni, che aveva come leit –motiv, che mi sembra ancora d’ascoltare dalla sua voce: sofferta: “Ci hanno sbarrato tutte le finestre”.
Uno di quei giorni mi confidò, d’impeto:” Ieri sera ho tolto il Crocifisso da capo del letto, e ci ho messo un ritratto di Beethoven”. Ancora sulla voce di Domenico. Cantava anche nel coro del Liceo, ed aveva l’eroismo, per un tenore, soprattutto italiano, di tener vigorosamente a freno l’istinto di d’ esibire i vari aspetti della sua superiore vocalità, per non oscurare gli altri, e per l’armonia dell’insieme. Mi disse che non aveva mai cantato musica leggera. Ammirai profondamente la nettezza della sua insofferenza ad accondiscendere a qualcosa di sentito estraneo, futile. Capivo che artefare la sua impostazione vocale sarebbe stato per lui lo stesso che autoalterare l’essenza della propria personalità.
Nella seguente primavera fummo provocati ancora all’azione. Si trattava d’aiutare concretamente un pianista che si era dichiarato in condizioni economiche disperate, cercando dei donatori da invitare ad un suo concerto. Iniziammo un “battage” nella fascia medio alta della buona borghesia veliterna, raccogliendo una serie di rifiuti. Siccome essi erano stati particolarmente netti fra i droghieri, Domenico scelse questo appellativo per definire i praticanti questo atteggiamento di chiusura. E quando mi chiedeva cosa avesse fatto qualche comune amico, ed io rispondevo che s’era tirato indietro, prorompeva, con spasimo più che con disprezzo:”Anche lui è un droghiere!”nella sua voce c’erano l’altezza, l’intensità ed il timbro dell’invettiva sartriana contro il borghese.
In delle sere di quel maggio, sulle selciate vie veliterne, ad un ritmo incalzante che era stato memorizzato dai suoi garretti ascoltando “Una notte sul monte Calvo”, mi confidò una sua passione in corso. Temetti che tanto bruciante intensità di sentimento potesse in qualche modo prosciugarlo, consumarlo. Ma non c’era questo pericolo: era il suo modo di essere.
Due anni dopo venne ancora a casa mia. Mi parlò del personaggio cechoviano di Vlajevskij, con un travolgente entusiasmo. Mi parlò delle malattie che non si possono guarire. Forse mi vide schiacciato e smarrito sotto quanto aveva evocato, ed allora, con occhi scintillanti ed un tono di sferzante speranza, m’investì: “Limiti! Limiti! Che devono essere superati!” Qualche altra visita, vibrante di confidenza. Poi più nulla, per decenni. Ma ero ben lontano dal dimenticarlo. Lo feci protagonista d’una mia operetta narrativa di fine anni settanta, immaginando che si fosse allontanato dalle nostra fede giovanile, e come l’avesse poi ritrovata. Poi, quando, a fine millennio, scrissi sui miei anni del Liceo, non mi diedi pace finchè non riuscii a trovarlo, tramite il fratello Giorgio. E ci potemmo riabbracciare quando si concesse un rientro nella sua Albano. Quel lungo colloquio me lo mostrò nella pienezza della propria maturità intellettuale, umana e creativa. Divorai e diffusi la sua opera sugli Indiani d’America, e divenni insaziabile dei suoi articoli sulla stampa vicentina, che mi facevano provare il senso profondo dell’espressione del Rabbi “parole che sono spirito e vita”.
Circostanze contingenti mi avevano fatto respirare l’atmosfera dell’Islam, e naturalmente glielo lo confidai. Quasi con sorpresa m’accorsi che, superando ogni incertezza o tiepidezza, lui si lanciava su quella strada. Ho la lieta certezza che, come verso gli insorti magiari, gli autoctono delle Americhe, i resistenti curdi, la causa decisiva del suo slancio, dopo le aggressioni occidentali all’Afganistan ed all’Iraq, era sempre la stessa: schierarsi a difesa di chi ha la ragione, ma non la forza. La stessa, ancora, che lo aveva spinto alla professione di chiamato in aiuto, cioè avvocato. La stessa che animava la sua attività sindacale. La stessa che, a Porta san Paolo, nel luglio del ‘60, lo aveva opposto, a piedi e disarmato, alle cariche di cavalleria dei carabinieri.
Credo di non parlare solo per me, ma anche per altri, soprattutto chi gli è stato vicino e chi ha il suo sangue nelle proprie vene, dicendo che il suo non esser più fra noi ha lasciato un vuoto da smarrimento, un gelo, uno stupore amaro del non veder più fluire il corso irrefrenabile della sua creatività. Al calore magmatico della sua grande anima forse avrebbe potuto operare la fusione tra la concezione del divino risalente a Platone e spintasi poi fino a quella illuminista, quella dei nativi delle praterie e montagne del continente nuovo, quella della civiltà islamica. Tra Dio, il Grande Spirito, ed Allah. Se e come sia avvenuta, è il mistero che è chiuso in lui. E’ certo che Domenico ha respirato, e ci ha fatto respirare, di queste supreme visioni, la recondita armonia.